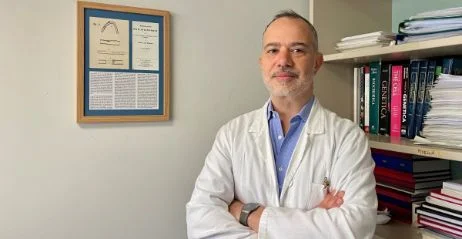Le nuove frontiere delle terapie cellulari del diabete di tipo 1
PUBBLICATO IL 24 SETTEMBRE 2025
“Il diabete di tipo 1 è un esempio di malattia la cui gestione quotidiana è completamente affidata alla persona che ne soffre. I pazienti devono infatti imparare a prevedere quanto mangeranno, e quindi quanto zucchero introdurranno, e quindi quanta insulina, e in quale momento, dovranno iniettarsi per tenere sotto controllo la glicemia, cioè i livelli di zucchero nel sangue.
È un lavorio costante del cervello, che deve calcolare, anticipare, prevedere, tutti i compiti che normalmente sono svolti dal pancreas, le cui cellule sono naturalmente calibrate per regolare finemente la glicemia. Quando questo controllo fine viene a mancare, come accade nel diabete di tipo 1, allora è come se dovessimo ricordarci in ogni momento di respirare”.
Così racconta il prof. Lorenzo Piemonti, primario dell’Unità operativa di Medicina rigenerativa e dei Trapianti presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore associato all’Università Vita-Salute San Raffaele.
Lo scorso 20 giugno, la rivista The New England Journal of Medicine ha pubblicato uno studio clinico che ha provato la sicurezza e l’efficacia di un farmaco cellulare che ha reso 10 pazienti affetti da diabete di tipo 1 indipendenti dalla somministrazione di insulina a 1 anno dalla singola infusione.
Il farmaco consiste di cellule di isole pancreatiche ottenute dal differenziamento di cellule staminali pluripotenti. Le cellule staminali pluripotenti possono infatti generare tutti i tessuti di un corpo adulto, comprese le isole pancreatiche contenenti le cellule beta, produttrici di insulina, che sono danneggiate nel diabete di tipo 1.
Questi risultati sono stati ottenuti nell’ambito di una più ampia sperimentazione che tuttora coinvolge numerosi istituti di ricerca negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, compresa l’Italia, dove l’Ospedale San Raffaele di Milano è l’unico centro partecipante.
“Una singola dose di farmaco nei pazienti con diabete di tipo 1 non ben controllato li ha resi indipendenti dall’iniezione di insulina esogena (esterna) a 1 anno dalla somministrazione. In altri termini, dopo un anno dalla ricezione del farmaco, queste persone non avevano più bisogno di iniettarsi insulina per tenere sotto controllo la glicemia.
Questi risultati, se confermati su un campione più numeroso di persone, suggeriscono la possibilità di una terapia alternativa all’insulina per il diabete di tipo 1”, spiega il professore, con il quale abbiamo ripercorso le tappe della ricerca che hanno condotto a questa importante svolta terapeutica.
Il diabete di tipo 1, una malattia autoimmune
In Italia circa 300.000 persone soffrono di diabete di tipo 1, una malattia in cui il sistema immunitario attacca, distruggendole, le cellule beta del pancreas, le quali normalmente rilasciano l’ormone insulina per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.
“Le cause del diabete di tipo 1 sono tuttora sconosciute. Esiste una predisposizione genetica tale per cui in una storia familiare dove vi sia un parente di primo grado affetto (dal diabete di tipo 1) vi è un rischioso aumento di sviluppare la malattia che passa da 1 su 300 casi a 1 su 20 casi. Tuttavia, il 90% delle persone che si ammalano di diabete di tipo 1 non ha una storia di familiari affetti”, racconta il professor Piemonti.
Una volta chiamato “diabete giovanile”, oggi si ritiene che il diabete di tipo 1 sia una malattia molto più complessa, che nel 50% dei casi esordisce in età pediatrica, ma che nel restante 50% può manifestarsi molto più tardi nella vita di una persona.
I sintomi del diabete di tipo 1
I sintomi classici dell’esordio clinico sono bere molto e urinare molto. Il termine "diabete" deriva dal verbo greco diabaínō, che significa "attraversare" o "passare attraverso", a indicare il rapido passaggio dei liquidi attraverso il corpo. Fu il medico greco Areteo di Cappadocia, nel II secolo d.C., a utilizzare questo termine per descrivere la condizione caratterizzata da una perdita anomala di liquidi attraverso le urine.
Questi sintomi possono essere preceduti da stanchezza, tendenza a mangiare molto e alterazioni reversibili della vista. Se non riconosciuti in tempo, i sintomi del diabete possono sfociare in un grave scompenso metabolico sistemico chiamato chetoacidosi metabolica, che può condurre anche alla morte.
La terapia con l’insulina e la regolazione fine della glicemia
Oggi la somministrazione di insulina, derivante dalla sintesi in laboratorio, è lo standard terapeutico per il diabete di tipo 1.
Esistono sensori che, posti sulla pelle, misurano i livelli sottopelle di glicemia, comunicandoli a dei microinfusori, piccole pompe che, in risposta, iniettano quantità predefinite di insulina.
“Quando si verificano rapide variazioni del fabbisogno insulinico, come dopo un pasto, il sistema automatico può non essere in grado di adattarsi immediatamente. In questi casi, è il paziente a dover intervenire, regolando la quantità di insulina da somministrare.
Il cervello, quindi, deve supplire a una funzione che in un corpo sano viene svolta automaticamente dal pancreas: le cellule beta rilasciano infatti, entro pochi secondi, la quantità di insulina necessaria a bilanciare l’aumento della glicemia”, spiega il professore.
Sebbene dalla sua prima applicazione negli anni ‘20 del ‘900 la terapia con insulina abbia salvato milioni di vite di pazienti con diabete di tipo 1, essa non è risolutiva della malattia. In particolare, essa non riesce a riprodurre la fine calibrazione della glicemia svolta dalle isole di un pancreas sano.
Talvolta, la somministrazione di insulina esogena può abbassare troppo i livelli di zucchero nel sangue e portare a ipoglicemia, che a sua volta può, per esempio, causare improvvisa perdita di conoscenza e altri problemi per i pazienti.
Nel tentativo di imitare quanto più fedelmente possibile la regolazione naturale della glicemia, i ricercatori hanno messo a punto già negli anni ‘60 del ‘900 il trapianto di pancreas, da cui è derivato, negli anni ‘80, il trapianto delle sole isole pancreatiche.
Il primo trapianto di isole pancreatiche in Europa è stato svolto nel 1989 proprio al San Raffaele di Milano.
“Per tenere sotto controllo la glicemia non abbiamo bisogno del pancreas intero, ma delle sole isole pancreatiche, ovvero dei grappoli di cellule che costituiscono appena il 1-2% di tutta la massa dell’organo. I pazienti che ricevono il trapianto delle sole isole pancreatiche diventano, nel 70% dei casi, indipendenti dall’insulina esogena, vale a dire che grazie al trapianto non hanno bisogno di iniettarsi l’ormone. Questa indipendenza viene mantenuta per circa 6-7 anni”, spiega il professore.
Tuttavia, chi riceve il trapianto delle sole isole pancreatiche deve sottoporsi in parallelo alla terapia con farmaci immunosoppressori, per impedire che il sistema immunitario attacchi e distrugga le cellule trapiantate. Inoltre, bisogna avere a disposizione un certo numero di pancreas donatori, compatibili con i riceventi, da cui estrarre una quantità adeguata di isole da trapiantare.
Per questo motivo, gli scienziati hanno negli anni lavorato per ricercare fonti potenzialmente illimitate di isole pancreatiche, giungendo così agli importanti risultati con cui abbiamo aperto questa storia.
Cellule staminali pluripotenti: una risorsa potenzialmente infinita di isole pancreatiche
Torniamo allo studio del New England Journal of Medicine del 20 giugno scorso, che ha provato l’efficacia e la sicurezza di un farmaco che ha reso 10 pazienti con diabete di tipo 1 indipendenti dalla somministrazione di insulina esogena.
Il farmaco consiste di cellule di isole pancreatiche ottenute da cellule staminali pluripotenti. Le cellule differenziate sono infuse nei pazienti attraverso la vena porta per giungere al fegato, dove si insediano per regolare normalmente la glicemia, senza produrre effetti collaterali significativi.
Dopo 1 anno dalla singola infusione del farmaco, sono stati ripristinati i livelli fisiologici di glucosio in 12 dei pazienti trattati. Di questi, 10 non hanno più avuto bisogno dell’insulina esogena, mentre 2 hanno ridotto, rispettivamente, del 70% e del 36% la dose di ormone richiesta.
Le cellule pancreatiche differenziate da staminali pluripotenti risolvono il problema della disponibilità limitata di pancreas donatori, che sussiste sia nel trapianto di pancreas sia nel trapianto di isole estratte direttamente dal pancreas.
Questo perché le cellule staminali sono per definizione in grado di moltiplicarsi indefinitamente e quindi generare una quantità potenzialmente illimitata di cellule che sono poi differenziate nei tessuti desiderati, ovvero le isole pancreatiche nel caso del trattamento del diabete di tipo 1.
Tuttavia, anche la nuova terapia basata su cellule staminali richiede l’utilizzo di immunosoppressori, per scongiurare l’eventualità che il sistema immunitario attacchi e distrugga le cellule infuse.
“Si ripresenta quindi il problema dell’immunosoppressione, che di per sé espone i pazienti trattati al maggior rischio di sviluppare infezioni e può compromettere la funzionalità dei reni”, commenta il professore.
L’immunosoppressione rimane lo svantaggio principale anche di un’altra terapia che impiega cellule di isole pancreatiche derivate da cellule staminali pluripotenti, ma in questo caso trapiantate nella parete addominale, piuttosto che nel fegato.
Questa seconda terapia con isole derivanti da staminali pluripotenti è stata sviluppata da un gruppo di ricerca dell’Università di Peking, che lo scorso ottobre 2024 ha pubblicato sulla rivista Cell promettenti risultati di efficacia e sicurezza ottenuti in una paziente con diabete di tipo 1.
“Anche in questo caso, la persona ha raggiunto dopo un anno l’indipendenza dall’insulina grazie al trapianto di cellule differenziate a partire da staminali pluripotenti. In questa seconda terapia, le cellule sono trapiantate in una zona della parete addominale relativamente più accessibile e monitorabile rispetto al fegato”.
A oggi, sono 3 i pazienti diabetici di tipo 1 trattati dal gruppo cinese: tutti e 3 insulino indipendenti, ma necessitano ancora della terapia con immunosoppressori.
Verso un futuro senza immunosoppressori
La ricerca nell’ambito delle terapie cellulari del diabete di tipo 1 è rivolta dunque verso un futuro senza immunosoppressione. L’idea è rendere le cellule trapiantate invisibili al sistema immunitario dei pazienti riceventi, cosicché esse non vengano attaccate e distrutte.
È un obiettivo complesso da raggiungere: il sistema immunitario è naturalmente progettato per proteggerci da qualsiasi agente che non sia riconosciuto come proprio dell’organismo e impiega, allo scopo, un esteso battaglione di cellule immunitarie che non si danno facilmente per vinte.
La ricerca sta comunque procedendo verso 2 strade possibili:
- le cellule da trapiantare vengono inserite in una matrice di gel arricchito con molecole che bloccano localmente la funzione delle cellule immunitarie. Questa inibizione locale, ma non sistemica, del sistema immunitario dovrebbe proteggere le cellule trapiantate, che possono così sopravvivere e funzionare, senza provocare gli effetti collaterali dell’immunosoppressione sistemica. La strategia si è dimostrata promettente nei primati non umani e il prossimo passo sarà testarla negli uomini;
- le cellule da trapiantare sono trattate con strumenti di ingegneria genetica per rimuovere le molecole che le rendono riconoscibili dal sistema immunitario. Questa strategia è stata testata in un paziente in Svezia, nel quale sono state trapiantate, nel muscolo dell’avambraccio, cellule pancreatiche ingegnerizzate per essere invisibili al sistema immunitario. Dopo 3 mesi dal trapianto, le cellule non sono ancora state rigettate.
Delle 2 strade, quella basata sull’ingegneria genetica sembra essere la più promettente. La ricerca sta lavorando attivamente per ottimizzare la produzione sicura, efficace e su vasta scala delle cellule ingegnerizzate.
“Non possiamo prevedere i tempi con cui disporremo di una terapia cellulare del diabete di tipo 1 che non necessiti più dell’immunosoppressione. È plausibile che si passerà per fasi intermedie caratterizzate da un regime di immunosoppressori più blando, prima di poter farne a meno del tutto, ma bisogna essere prudenti nel fare previsioni.
Considerando, però, le innovazioni della ricerca degli ultimi vent’anni, possiamo dire che oggi è già nata la prima generazione di pazienti con diabete di tipo 1 che riceverà il trattamento su vasta scala con isole pancreatiche derivate da cellule staminali. Il nostro prossimo impegno sarà quello di poterla rendere disponibile e sostenibile al numero maggiore di persone con diabete di tipo 1”, conclude il professor Piemonti.