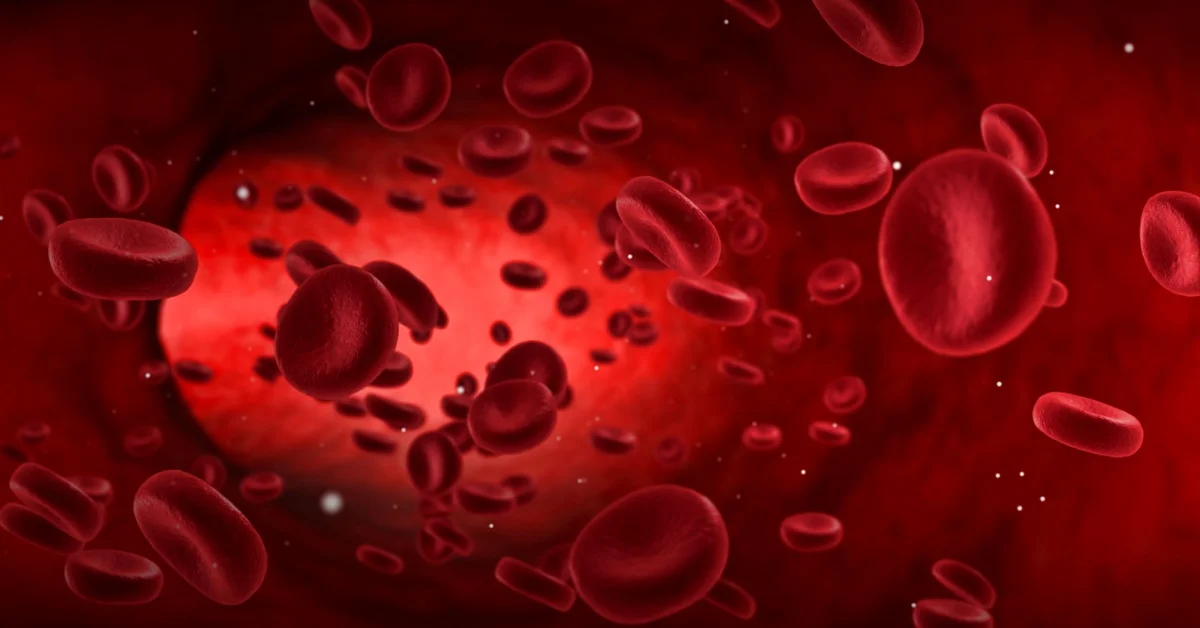
Cos'è l'eritrocitosi e come si cura
PUBBLICATO IL 01 APRILE 2025
L'eritrocitosi è una condizione caratterizzata da un numero anormalmente elevato di eritrociti (globuli rossi) nel sangue. Questa condizione può essere primaria o secondaria, a seconda delle cause sottostanti.
Ne parliamo con il dottor Daniele Sannipoli, medico della Disease Unit Malattie Mieloproliferative dell’Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, diretta dal professor Fabio Ciceri.
Le caratteristiche dell’eritrocitosi
“Con il termine eritrocitosi si intende un aumento assoluto o relativo dei globuli rossi circolanti - spiega il dott. Sannipoli -, definito da valori di:
- emoglobina (Hb) (proteina contenuta nei globuli rossi) >16.5 g/dL negli uomini e >16 g/dL nelle donne;
- ematocrito (esame che misura il volume dei globuli rossi nel sangue) >49% negli uomini e >48% nelle donne.
Questi parametri devono essere documentati in più misurazioni e contestualizzati rispetto alle caratteristiche del paziente (peso, storia di fumo, vita ad alta quota, ecc.)”.
I tipi di eritrocitosi
“Le forme di eritrocitosi sono molteplici e si suddividono in primarie e secondarie, entrambe con possibili cause congenite o acquisite”, prosegue.
Le eritrocitosi primarie
Le eritrocitosi primarie derivano da mutazioni genetiche che causano un’anomala produzione di globuli rossi e si distinguono in:
- forma congenita (rara, diagnosticata generalmente in età pediatrica): causata da mutazioni del recettore per l’eritropoietina (EPO), l’ormone principale che stimola l’eritropoiesi (processo di formazione dei globuli rossi);
- forma acquisita: la più comune è la Policitemia Vera (PV), una neoplasia mieloproliferativa del midollo osseo associata, nella quasi totalità dei casi, a mutazioni del gene JAK2. La mutazione più frequente, JAK2V617F, rende la proteina costitutivamente attiva, inducendo una proliferazione incontrollata delle cellule emopoietiche mature.
La PV fa parte delle Neoplasie Mieloproliferative Philadelphia-negative (MPN Ph-), insieme a trombocitemia essenziale e mielofibrosi. A differenza di altre eritrocitosi, la PV comporta un aumentato rischio di trombosi ed emorragie, rendendo necessaria una valutazione ematologica e successiva presa in carico.
Le eritrocitosi secondarie
Le eritrocitosi possono essere secondarie a molteplici cause. Le principali cause includono:
- broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e altre malattie polmonari croniche, frequenti nei fumatori;
- sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS): più frequente nei pazienti obesi, è caratterizzata da delle pause patologiche del respiro durante la notte che possono indurre un’ipossigenazione cronica. Tra gli altri sintomi, la stanchezza diurna e il respiro russante possono essere indici di OSAS. La diagnosi si basa sulla valutazione di un esame chiamato polisonnografia che registra, durante la notte, alcuni parametri fisiologici come gli atti respiratori, i livelli di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e alcuni movimenti nel sonno. L’esame può essere eseguito quasi sempre al domicilio, è del tutto indolore e non invasivo;
- malattie cardiache congenite: in alcune anomalie anatomiche, sussiste una comunicazione patologica tra le sezioni destra e sinistra del cuore, inducendo una ridotta ossigenazione dal sangue arterioso e dunque un’eritrocitosi compensatoria;
- tumori solidi tra cui tumori cerebellari, miomi uterini, epatocarcinomi e carcinomi a cellule renali: in queste neoplasie, le cellule tumorali producono elevati livelli di eritropoietina, inducendo una stimolazione patologica del midollo osseo;
- farmaci, come alcuni antidiabetici e diuretici, testosterone, anabolizzanti e steroidi;
- stenosi dell’arteria renale;
- altre sindromi rare.
Da non trascurare le eritrocitosi relative, dovute a disidratazione osmotica, ad esempio, in pazienti diabetici con scarso controllo glicemico”.
I sintomi dell’eritrocitosi
L’aumento dei globuli rossi può provocare un incremento della viscosità sanguigna, che può generare sintomi tra cui:
- prurito, formicolii, parestesie;
- capogiri, vertigini e cefalea;
- pelle arrossata (facies pletorica), dolore urente ai palmi delle mani (eritromelalgia);
- disturbi del visus, causati dal rallentamento del flusso sanguigno retinico.
“Nelle forme ematologiche primitive - continua lo specialista - la mutazione JAK2 può indurre l’aumento volumetrico della milza (splenomegalia) con possibile calo dell’appetito, dimagrimento e dolore sottocostale sinistro.
Inoltre, nei pazienti affetti da Policitemia Vera (PV) l’eritrocitosi si accompagna a una spiccata alterazione della coagulazione, sia in senso pro-trombotico (più frequente, anche in sedi atipiche), sia emorragico (sanguinamenti spontanei non giustificati)”.
Come trattare l’eritrocitosi secondaria
“Per le forme di eritrocitosi secondaria, la terapia dipende dalla causa sottostante - approfondisce -.
Nelle forme secondarie a patologie polmonari, l’eritrocitosi è spesso un meccanismo di compenso che va mantenuto al fine di evitare peggioramenti del quadro generale. In questo caso, è sempre indicata la sospensione dell’abitudine al fumo. Da valutare, inoltre, l’utilizzo di terapia antiaggregante ed eventualmente l’avvio di una terapia specifica indicata da altri specialisti (es. cardiologo e pneumologo).
In questi casi, il trattamento della disfunzione respiratoria, il miglioramento dell’ossigenazione e in generale la correzione dello stile di vita possono indurre di per sé una riduzione dell’eritrocitosi. Talora può essere necessaria la correzione di difetti anatomici.
Per il trattamento delle OSAS, può essere utile la perdita di peso, l’igiene del sonno e, nei casi più severi, l’uso di dispositivi notturni come la CPAP. Si tratta di un dispositivo che permette di evitare che, durante la notte, le vie respiratorie si chiudano in modo eccessivo mantenendo un flusso respiratorio costante. Una volta adattata al portatore, la CPAP può essere utilizzata al domicilio dal paziente in autonomia.
Per le forme secondarie a tumori solidi, il trattamento è oncologico e richiede la presa in carico da parte dello specialista di riferimento: esso può richiedere chemio-immunoterapia, radioterapia, chirurgia o la combinazione delle 3”.
Come trattare la Policitemia Vera
Per la Policitemia Vera, invece, il trattamento ematologico viene indicato dallo specialista ematologo dopo approfondimento diagnostico. “A meno di controindicazioni specifiche, tutti i pazienti affetti hanno indicazione a terapia antiaggregante a basso dosaggio - asserisce il medico -.
Per i pazienti giovani senza eventi cardiovascolari pregressi, la salassoterapia può essere sufficiente a controllare la patologia e ridurre il numero di globuli rossi circolanti.
Per i pazienti a rischio cardiovascolare più elevato per età o comorbidità, oppure con pregressi eventi trombotici, è necessario avviare una terapia farmacologica che permetta di controllare l’eritrocitosi e di conseguenza mitigare il rischio di eventi severi associati a questa condizione.
La terapia tradizionale prevede l’utilizzo a dosaggio variabile dell’idrossiurea, farmaco noto e in uso da molti anni e di cui è ben conosciuto il profilo di tossicità. Negli ultimi anni, sono state introdotte nuove terapie che hanno ampliato le possibilità terapeutiche, in particolare l’interferone e il ruxolitinib (un inibitore della via di JAK).
L’interferone, farmaco noto da molti anni e ora disponibile in una formula a rilascio prolungato, prevede una somministrazione sottocutanea ogni 15 giorni e ha mostrato non solo di poter controllare i sintomi associati all’eritrocitosi, ma anche di ridurre la quantità di cellule mutate nel midollo osseo.
Il ruxolitinib, invece, è un farmaco più recente, ma già di uso consolidato per la patologia ed è particolarmente indicato nei pazienti molto sintomatici e con splenomegalia importante.
“La presa in carico ematologica costante, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari, la gestione multidisciplinare con cardiologi, nutrizionisti e medici esperti di dislipidemie, l’uso singolo o combinato di questi farmaci - conclude Sannipoli - permette nella quasi totalità dei pazienti affetti da Policitemia Vera di mantenere una buona aspettativa e qualità di vita”.