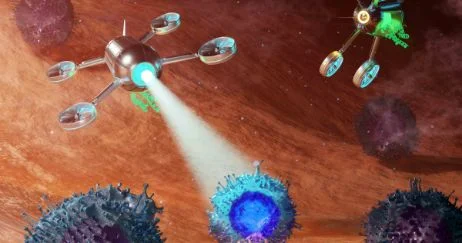Epatite B: come agisce il virus, le terapie attuali e il vaccino come prevenzione
PUBBLICATO IL 28 LUGLIO 2025
100 anni fa, il 28 luglio 1925, nasceva Baruch Blumberg, futuro Premio Nobel 1976 per le sue ricerche sulle malattie infettive e per la scoperta di un virus in circolazione da millenni, il virus dell’epatite B. In suo onore, ogni anno il 28 luglio si celebra la Giornata Mondiale delle Epatiti.
Blumberg fu pioniere anche dei primi vaccini contro l’epatite B, lo strumento più prezioso che abbiamo per prevenire l’infezione e la malattia, la quale tuttavia rimane una delle maggiori sfide della sanità mondiale.
L’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato nel 2022 che nel mondo almeno 254 milioni di persone convivono con l’epatite B, “ma questa potrebbe essere una sottostima, considerando che, soprattutto nei Paesi più poveri del Mondo, è molto difficile sia testare la presenza del virus sia assicurare una copertura vaccinale adeguata.
Oltretutto, la stragrande maggioranza delle persone cronicamente infette non sa di convivere con il virus”, commenta il professor Luca Guidotti, vicedirettore scientifico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, professore ordinario di Patologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e riconosciuto leader nel campo, insignito nel 2023 del Distinguished Award in Hepatitis B Research, il più prestigioso riconoscimento internazionale nel settore dell’epatite B.
Un virus silente: come agisce
Il virus dell’epatite B (dall’inglese, Hepatits-B Virus, HBV) è fatto di DNA e proteine virali. Esso riconosce principalmente le cellule del fegato, i cosiddetti epatociti, che infetta. Una volta entrato negli epatociti, HBV può replicarsi per formare nuove particelle virali, ma di per sé solitamente non uccide le cellule, per cui in gergo si definisce non citopatico.
“HBV è fortemente non citopatico: non danneggia direttamente gli epatociti che infetta - spiega il professor Luca Guidotti -. È il sistema immunitario che, riconoscendo le componenti virali, reagisce attaccando e distruggendo le cellule infettate. È in questo momento che l’infezione da HBV si manifesta indirettamente attraverso un’infiammazione locale del fegato e con i sintomi clinici associati alla malattia”.
Nella maggior parte dei casi, l’infezione acuta da HBV contratta in età adulta si risolve spontaneamente nell’arco di alcuni mesi grazie alla risposta immunitaria, senza necessità di trattamenti specifici.
Tuttavia, in una minoranza di casi (meno del 5%), l’infezione diventa cronica: ciò significa che il sistema immunitario non riesce a eliminare il virus, che persiste nell’organismo. Il rischio di cronicizzazione dell’infezione aumenta quanto più giovane è il soggetto colpito, arrivando a oltre il 90% nei neonati che contraggono il virus al momento del parto.
“Una delle ipotesi più accreditate è che questo accada perché il sistema immunitario del neonato non è ancora completamente sviluppato - continua il professor Guidotti -. Un sistema immunitario immaturo può considerare le componenti virali come parte integrante dell’organismo, e quindi non attaccare le cellule infettate in maniera appropriata.
Con il passare del tempo, può verificarsi un cambiamento: per ragioni ancora non del tutto comprese, un sistema immunitario che rimane parzialmente disfunzionale può iniziare ad attaccare gli epatociti infettati, senza tuttavia riuscire a eradicare completamente il virus. Questo porta all’instaurarsi di un’infiammazione cronica di bassa intensità, che si manifesta con episodi ricorrenti di danno epatico lieve.
Nel lungo periodo, questa condizione può però evolvere in complicanze gravi come la fibrosi e la cirrosi epatica, fino a sfociare in una forma di tumore primario del fegato nota come carcinoma epatocellulare.
Le attuali terapie contro l’epatite B cronica
Oggi sono disponibili farmaci antivirali “generici” a basso costo, somministrati per via orale, sicuri ed estremamente efficaci nel:
- controllo del virus;
- rallentamento della progressione della malattia.
“Analogamente ai farmaci antiretrovirali utilizzati contro l’HIV, questi antivirali riducono in modo significativo la capacità replicativa del virus, abbattendo il rischio di gravi complicazioni - spiega il professor Guidotti -. Tuttavia, non sono in grado di eradicare il virus, rendendo necessaria un’assunzione continuativa, spesso per tutta la vita”.
Nello specifico, questi farmaci anti-HBV inibiscono la sintesi del nuovo DNA virale, riducendo non solo la formazione di nuove particelle infettive, ma anche la possibilità che frammenti di DNA virale difettoso si integrino nel genoma dell’ospite. Tale integrazione rappresenta un meccanismo potenzialmente rilevante nei processi trasformativi che possono condurre allo sviluppo del carcinoma epatocellulare.
Le linee guida attuali restringono l’applicazione di questi farmaci antivirali alle:
- persone che possiedono elevati livelli di DNA virale e aumentate concentrazioni di enzimi del fegato;
- persone nelle quali siano presenti segni di fibrosi, cioè cicatrizzazione del tessuto epatico.
Questi criteri richiedono peraltro la necessità di testare e monitorare i pazienti continuamente nel tempo, il che non è sempre possibile in ambienti con risorse limitate. Questo significa che solo una piccola parte dei pazienti che nel mondo convivono con l’infezione da HBV cronica riceve le terapie antivirali disponibili.
La proposta di ampliare l’accesso alle terapie
Di recente è apparsa una pubblicazione sulla rivista The Lancet Gastroenterology and Hepatology, tra i cui autori figura anche il professor Guidotti, in cui si propone:
- di ampliare l’accesso della popolazione ai test diagnostici per la presenza di HBV, soprattutto nelle aree con reddito medio-basso;
- di rivedere i criteri di eleggibilità dei pazienti alla terapia antivirale, al fine di renderla accessibile a un maggior numero di persone.
Specificamente, gli autori propongono di rendere i farmaci antivirali accessibili a tutte le persone con qualsiasi livello di HBV nel sangue che ricadano in una delle seguenti categorie:
- fanno richiesta del trattamento antivirale;
- hanno una storia familiare di cirrosi o tumore del fegato;
- hanno più di 30 anni;
- presentano segni di infiammazione o danno al fegato;
- presentano altre condizioni o fattori di rischio che supportano l’inizio del trattamento antivirale.
Tra i rischi associati con la possibile estensione della terapia a un maggior numero di pazienti possono figurare:
- malattie ai reni o alle ossa nel 5% delle persone trattate;
- possibile sviluppo di resistenza da parte del virus ai farmaci;
- ricomparsa di infiammazione grave del fegato se viene sospeso il trattamento;
- il costo del trattamento, pur essendo molto contenuto nel mondo industrializzato, può comunque risultare proibitivo per pazienti che vivono in aree particolarmente svantaggiate, soprattutto in alcune regioni dell’Africa e dell’Asia.
“Noi riteniamo che i benefici di espandere la somministrazione dei farmaci antivirali a un bacino più ampio di soggetti portatori cronici di HBV superino i rischi associati con questa estensione del trattamento”, spiega il professore.
La riduzione della replicazione del virus da parte dei farmaci antivirali difatti si traduce indirettamente in una attenuazione dell’infiammazione e del rischio di sviluppare le complicanze sopracitate dell’epatite B cronica.
Inoltre, la riduzione della replicazione virale e della viremia indotta dai farmaci antivirali è associata a una minore integrazione del virus nel genoma dell’ospite, contribuendo ulteriormente a ridurre il rischio di carcinoma epatocellulare.
“È indubbio che la conduzione di studi clinici finalizzati a raccogliere un maggior numero di dati a supporto dei potenziali benefici derivanti dall’ampliamento dell’accesso alle terapie antivirali per un numero più vasto di pazienti porterà importanti vantaggi”, sottolinea il professor Guidotti.
La prevenzione è la migliore strategia contro l’epatite B: il vaccino
Fortunatamente, da molto tempo abbiamo a disposizione un vaccino sicuro e molto efficace nel prevenire l'epatite B. Esso è stato sviluppato poco dopo la scoperta di HBV ed è costituito da 2 proteine innocue, presenti nell’involucro di HBV.
Quando somministrate queste proteine vengono riconosciute dal sistema immunitario, che attiva così risposte difensive mirate. Grazie agli anticorpi e ai linfociti T (cellule del sistema immunitario) specifici per il virus così sviluppati, l’organismo è in grado di prevenire eventuali infezioni future da HBV.
“Dal 1991 in Italia è obbligatorio vaccinarsi contro HBV a partire dai primi mesi di vita. Il vaccino è molto sicuro ed efficace nel 95-98% dei casi e offre una protezione immunitaria a lungo termine”, afferma il professor Guidotti.
In Italia i neonati devono ricevere obbligatoriamente 3 dosi di vaccino nell’arco del primo anno di vita.
Se i neonati hanno una madre portatrice del virus, è necessario attenersi a uno schema vaccinale specifico. Il vaccino è disponibile anche per gli adolescenti o gli adulti che per qualche motivo non sono stati vaccinati alla nascita.
Per tenersi aggiornati sullo schema vaccinale più adeguato, è opportuno consultare il proprio medico di competenza.